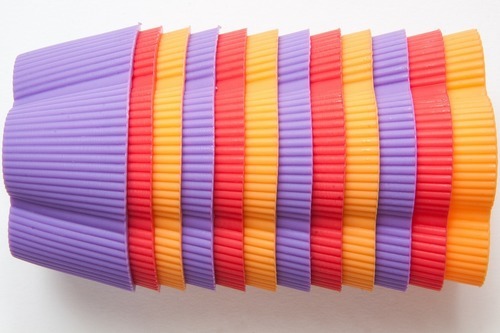Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) stanno cambiando il modo di produrre e consumare energia in Italia. Queste associazioni permettono ai cittadini di essere protagonisti della transizione energetica, producendo e condividendo energia da fonti rinnovabili. I vantaggi? Risparmio, rispetto per l’ambiente e una comunità più unita.
Unirsi per un Futuro Sostenibile
Una Comunità Energetica Rinnovabile è un gruppo di persone, aziende, o enti che collaborano per produrre e consumare energia pulita a livello locale. Immagina un gruppo di vicini, un condominio, o piccole imprese che si uniscono per installare pannelli solari: questa è l’idea di base di una CER. La legge italiana, in linea con le direttive europee, definisce la CER come un soggetto giuridico autonomo, basato sulla partecipazione volontaria. I membri, che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI) o enti locali, devono trovarsi vicino agli impianti di produzione. L’obiettivo principale, come precisa Osservatori.net, non è il profitto, ma creare benefici ambientali, economici e sociali per la comunità.
Come Funziona in Pratica?
I membri di una CER collaborano per creare impianti che producono energia da fonti rinnovabili, come pannelli solari, impianti eolici, idroelettrici o a biomasse. L’energia prodotta serve a soddisfare i bisogni dei membri. Quella in eccesso può essere immessa nella rete elettrica o condivisa, generando ulteriori vantaggi economici grazie a specifici incentivi. Ogni impianto di una CER può avere una potenza massima di 1 MW, ma la CER stessa può avere più impianti. Tutte le utenze devono essere collegate alla stessa cabina di trasformazione primaria, come indicato da Sky TG24.
Autoconsumo Collettivo e Comunità Energetiche: Quali Differenze?
È importante distinguere tra autoconsumo collettivo e comunità energetiche. L’autoconsumo collettivo, come spiega PMI.it, si applica a gruppi di consumatori nello stesso edificio (ad esempio, un condominio). Le comunità energetiche, invece, coinvolgono soggetti diversi (cittadini, imprese, enti) in un’area più ampia, purché connessi alla stessa cabina primaria. Entrambi i modelli promuovono l’energia rinnovabile, ma con normative e ambiti di applicazione differenti.
I Vantaggi Concreti delle CER
Aderire a una CER offre vantaggi concreti, riassumibili in tre punti chiave:
Risparmio in Bolletta
Il vantaggio più evidente è la riduzione della spesa per l’energia. Grazie all’autoconsumo, i membri della CER dipendono meno dai fornitori tradizionali e risparmiano. A questo si aggiungono gli incentivi statali per l’energia condivisa, come tariffe incentivanti e contributi a fondo perduto. Questi incentivi, come spiegato da PMI.it, rendono l’investimento conveniente, accelerando il ritorno economico e garantendo un risparmio duraturo.
Un Aiuto all’Ambiente
Le CER sono uno strumento per la sostenibilità. Utilizzando fonti rinnovabili, riducono le emissioni di CO2, il principale responsabile del cambiamento climatico. Inoltre, la produzione di energia “a chilometro zero” minimizza le perdite di rete.
Una Comunità Più Forte
Le CER non sono solo un progetto energetico, ma anche sociale. Favoriscono la collaborazione, rafforzando il senso di comunità e la partecipazione. Un aspetto importante è la lotta alla povertà energetica, garantendo a tutti l’accesso a energia pulita a costi contenuti. Le CER sono un modello di democrazia energetica, con i cittadini al centro del sistema, come evidenzia Euricse.
Il Supporto dello Stato: Incentivi e Normative
Il governo italiano sostiene le CER. Il Decreto CER (Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023), entrato in vigore il 24 gennaio 2024, è un passo fondamentale, come riporta Certifico Srl.
Contributi a Fondo Perduto e Tariffe Vantaggiose
Il decreto prevede due forme di sostegno. Un contributo a fondo perduto, fino al 40% dei costi, per impianti in CER situate in comuni con meno di 5.000 abitanti (finanziato dal PNRR). E una tariffa incentivante sull’energia prodotta e condivisa, valida in tutta Italia. Questi incentivi sono cumulabili, come sottolinea Valori.it, rendendo l’adesione a una CER molto vantaggiosa.
Il Ruolo del GSE
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è centrale. Il GSE gestisce gli incentivi e fornisce assistenza a chi è interessato a una CER. Sul sito del GSE si trovano guide, documenti e strumenti utili, come la mappa delle cabine primarie.
Le CER in Italia: Una Realtà in Crescita
Le Comunità Energetiche Rinnovabili stanno crescendo in Italia. A maggio 2024, sono attive 46 CER, come riporta Rinnovabili.it. Un numero che testimonia un interesse crescente. La maggior parte usa impianti fotovoltaici, ma si va verso altre fonti rinnovabili, dimostrando la versatilità del modello. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha sottolineato l’importanza delle CER a “Key – The Energy Transition Expo 2025”, evidenziando l’impegno del governo, come si legge sul sito del MASE.
Non Solo Fotovoltaico
Sebbene il fotovoltaico sia predominante (87,4% degli impianti), si registra un interesse crescente per l’idroelettrico, l’eolico e le biomasse, a conferma della flessibilità delle CER.
Le Sfide da Affrontare
Nonostante la crescita, le CER affrontano alcune sfide. La burocrazia, le incertezze normative e le difficoltà nello scambio di dati sono ostacoli da superare, come evidenziato anche da Industria e Formazione. È fondamentale semplificare le procedure e garantire un quadro normativo chiaro per favorire lo sviluppo delle CER.
Oltre i Numeri: l’Impatto Sociale delle CER
Le CER non sono solo numeri e risparmio. Diverse iniziative in Italia dimostrano il loro impatto sociale, come evidenziato da LifeGate. Un esempio è la CER’O2z a Ozzano dell’Emilia, la prima Comunità Energetica Rinnovabile del comune, presentata ufficialmente, come riportato dal sito del Comune di Ozzano dell’Emilia. Questa iniziativa coinvolge cittadini e imprese, dimostrando i benefici tangibili per la comunità. Anche il settore privato supporta le CER, come dimostrano le FAQ di Enel Green Power.
Come Creare una CER: Guida Pratica
Avviare una CER è più semplice di quanto si pensi. Ecco i passi fondamentali:
Trova i Partecipanti
Il primo passo è riunire persone, aziende o enti interessati. Possono essere vicini, condomini, imprese, o enti pubblici (scuole, municipi). L’importante è essere collegati alla stessa cabina primaria.
Scegli la Forma Giuridica
La CER deve avere una forma giuridica. Le più comuni sono l’associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o la cooperativa. La scelta dipende dalle dimensioni e caratteristiche della comunità.
Realizza l’Impianto
Una volta costituita la CER, bisogna realizzare l’impianto di produzione di energia rinnovabile. La scelta della tecnologia dipende dalle risorse disponibili e dai bisogni.
Fai Domanda al GSE
Per accedere agli incentivi, bisogna presentare domanda al GSE, che fornisce informazioni e modulistica sul suo sito.
Un Futuro di Energia Condivisa
Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un’opportunità per l’Italia. Permettono ai cittadini di essere protagonisti di una transizione verso un sistema energetico sostenibile, decentralizzato e democratico. I benefici sono tanti: risparmio, tutela dell’ambiente, coesione sociale e lotta al cambiamento climatico. Le sfide non mancano, ma l’interesse crescente e l’impegno del governo indicano che le CER avranno un ruolo sempre più importante.
Partecipa al Cambiamento
Sei interessato a un futuro energetico più sostenibile? Informati sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, valuta la possibilità di aderire a una CER esistente o di crearne una nuova nella tua zona. Il futuro dell’energia è nelle nostre mani.